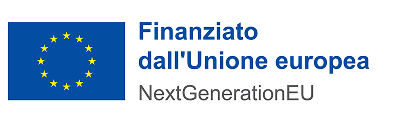Da patrimonio industriale dismesso a micro—comunità residenziali
BOXinBOX è un progetto di ricerca finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito dell’ecosistema iNEST, ideato da cinque aziende per esplorare la possibilità di riconvertire parte del patrimonio industriale dismesso del Friuli Venezia Giulia in micro-comunità residenziali. Case per anziani autosufficienti, residenze transgenerazionali, micronidi, spazi di lavoro e associativi: scenari che reinterpretano strategie progettuali e costruttive esistenti, le applicano a un contesto imprevisto e generano una nuova visione dell’abitare, fondata sulla qualità dello spazio, l’inclusione sociale e l’economia circolare.
Scrivici per maggiori informazioni!
Contattaci per maggiori informazioni o per registrati alla piattaforma BOXinBOX.
Che tu sia un proprietario di un edificio dismesso, un progettista, un'impresa o semplicemente curioso di conoscere nuove modalità di trasformazione del territorio, la nostra piattaforma ti offre strumenti, contatti e scenari concreti per agire.